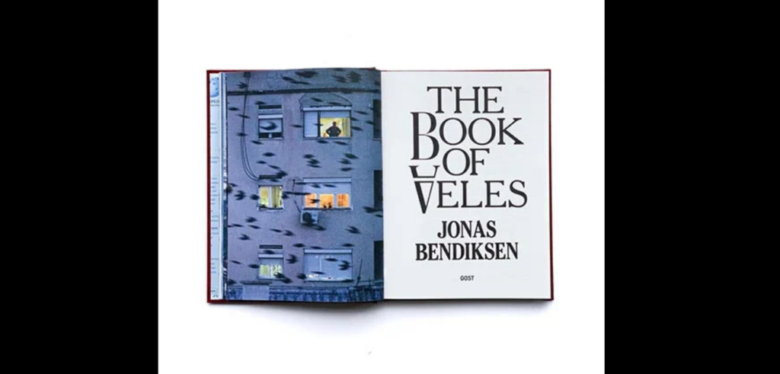Informazione e guerra: intervista a Valerio Nicolosi
In un momento storico in cui le notizie sulla guerra pervadono i giornali d’Italia, come raccontare il conflitto nella sua complessità? Quanto è importante informare ed essere informati in maniera approfondita e neutrale?
Abbiamo parlato di queste e altre tematiche con Valerio Nicolosi, giornalista di MicroMega e autore del podcast Voci da Kiev sotto assedio, che racconta la sua esperienza di inviato di guerra in Ucraina.
Perché hai pensato di dar vita ad un podcast? È stato un ragionamento di prodotto, considerato come più vendibile, oppure di narrazione, perché rendeva meglio il racconto?
È stata una scelta dettata da due ragioni: la prima è che il podcast è più comodo. MicroMega è una rivista di approfondimento: un pezzo è molto più lungo rispetto a quello di un quotidiano, ti porta via tanto tempo e in un contesto come quello ucraino non sempre sai se, ad esempio, ci sarà l’elettricità. La seconda è una questione narrativa: io avevo già fatto dei podcast (anche se di tipo diverso), perché mi piace come tipo di narrazione e, di conseguenza, avevo già confidenza col prodotto.
L’idea, in ogni caso, nacque quando il mio collega Daniele Nalbone mi chiese di mandargli un lungo audio per poi trascriverlo: a quel punto pensai di mandare comunque un lungo audio, però invece di farglielo trascrivere decisi di renderlo un podcast.
Credo che il podcast renda il racconto molto più intimo: il lettore non legge quello che scrivo, ma sente la mia voce, e inoltre in questo caso la sente live, con tanto di ragionamenti mentre parlo. Nel registrare, infatti, io mi scrivevo solo 5-6 parole chiave che diventavano la mia scaletta mentale, e sapevo che dovevo muovermi tra queste. Tuttavia, tra queste c’erano tanti ragionamenti e tanta stanchezza, quindi anche tante ripetizioni. Credo che la cosa bella di questo podcast sia proprio stata l’intimità.
Il tuo podcast è stato creato in un momento storico in cui il giornalismo è sempre più “social”, incentrato sul buon prodotto soprattutto a livello audiovisivo. Mentre eri a Kiev tu hai registrato da un telefono cellulare, senza tagli né lavori di post-produzione, riportando al centro “le storie”.
Nonostante ciò, hai raggiunto tantissime persone: è un segnale del fatto che, quando si parla di guerra, il pubblico sia ancora legato molto più alla storia che al miglior contenuto a livello audiovisivo?
Io credo, più che altro, che questo podcast abbia un unicum: di essere stato fatto live, letteralmente sotto assedio. In un altro contesto il minor livello di qualità tecnica che ne deriva non sarebbe giustificabile. Nel momento in cui lo riproponi in questa veste, da un’altra parte, secondo me non funziona.
Io già dal confine, ad esempio, montavo, perché registravo una voce e poi inserivo le interviste.
Quello che secondo me è interessante di questo podcast è proprio capire la sua unicità: ha funzionato perché c’era quel contesto lì. Neanche adesso sarebbe replicabile quel tipo di narrazione, quindi credo che vada rilegata a quel tipo di esperienza.
A questo proposito: quanti giovani, che oggi sono la categoria di persone che più si informa dai social, hanno ascoltato il tuo podcast?
In generale sono giovani: è proprio un prodotto pensato per loro, anche se il mio non lo è stato.
Secondo me è difficile far seguire un podcast troppo elaborato, dato che comunque la generazione dei ventenni di oggi fa fatica a seguire cose molto approfondite: infatti i podcast di altre persone sono di 7-8 minuti al massimo; i miei erano un po’ più lunghi ma anche perché rispecchiavano la rivista che, a prescindere dallo strumento, approfondisce. Ora invece vanno di moda questi podcast che in tre o cinque minuti ti dicono tutto, o ti raccontano una storia in sette minuti: funziona, ma a me lascia sempre un po’ così, perché dico “Vabbè, e quindi? Questo era l’inizio, ora raccontami il resto”.
Nel tuo podcast raramente sentivamo informazioni riportate dai media tradizionali. Hai perlopiù raccontato le storie degli individui che hai incontrato nel tuo cammino. Perché la tua narrazione è diversa e qual è stata l’intenzione di quest’ultima? Perché è importante fare questo tipo di narrazione?
Questo è il mio taglio. Dell’avanzamento delle truppe parla un giornale generalista, io non lavoro per un giornale generalista e non ho mai fatto quel tipo di informazione: potrei farlo ma non è quello che mi appassiona. Raccontare le persone vuol dire partire da una piccola storia per poi raccontare qualcosa di molto più grande: io sceglievo di partire dai vissuti delle persone per poi tornare a raccontare la guerra nella sua complessità.
Ho adottato questo stesso taglio anche in Palestina e anche con le rotte migratorie.
Sotto questo punto di vista quanto è importante, quando si racconta la guerra, informarsi da fonti che restituiscano a quest’ultima quella complessità che la caratterizza e che tu hai avuto modo di ricostruire?
Parlando di complessità partirei dalla mia esperienza: io non raccontavo tutto quello che avevo davanti, sceglievo proprio per restituire questa complessità.
Per esempio, io sono stato il primo a tirare fuori la storia dei disertori: nel momento in cui tutti stavano elogiando la grande resistenza del popolo ucraino io ho alzato la mano e ho detto “In realtà non è proprio così”. È vero che la maggioranza del popolo ucraino sta partecipando alla resistenza, ma c’è anche da valutare quest’altra realtà. Sono venuto a conoscenza della storia dei disertori da un articolo in ucraino (che ho tradotto), che riportava questa notizia dalla polizia di frontiera ucraina: da lì mi sono messo ad indagare.
L’idea di selezionare le storie per me era quindi volta alla restituzione della complessità.
Se in una guerra ci si informa velocemente si hanno informazioni parziali.
Pensi che le posizioni filo-russe presenti in Italia derivino da questo atteggiamento comunicativo atlantista e di parte che si è instaurato nel corso degli anni?
Diciamo che non aiuta, e ovviamente schiaccia noi che vorremmo ragionare.
Quando ho ricordato che il battaglione Azov è composto da nazisti mi hanno risposto che gli ucraini, ad un mio ipotetico rientro in Ucraina, mi avrebbero sputato in faccia per le mie parole. La prima reazione che una persona comune avrebbe davanti a questo tipo atteggiamento sarebbe di “tifare per l’altra parte”, o di chiedersi perché ci comportiamo come sudditi degli Stati Uniti all’interno della NATO (anche se in questa fase, per fortuna, abbiamo iniziare a fare dei distinguo).
Questo per dire che le posizioni eccessivamente atlantiste portano a un sentimento di contrasto che va verso l’altra parte.
La divisione “bipolare” creatasi con la guerra in Ucraina potrebbe influenzare anche la narrazione di futuri conflitti?
Non è solo questo conflitto che ha portato alla polarizzazione: siamo nell’era della polarizzazione, ed è veramente complesso fare informazione così. Siamo arrivati addirittura alla polarizzazione sui migranti: io mi sono occupato e mi occupo tutt’ora di rotte migratorie e appena salgo sulle navi delle ONG mi insultano (anche se sulla rotta balcanica funziona meno perché è meno polarizzata). Ogni tema è così: valeva per il COVID , così come per questa guerra e anche la prossima che ci interesserà.
Durante questa guerra c’è stato un “bombardamento mediatico”. Ricevevamo aggiornamenti ogni secondo, e siamo sicuri che tante persone siano rimaste tanti giorni con il telefono in mano, o con la televisione sempre accesa per guardare gli aggiornamenti. C’è la necessità di ricevere aggiornamenti costantemente? Questo modo di raccontare e seguire la guerra può essere considerato “efficace” e, soprattutto, “salutare” per coloro che la seguono?
Questo modo di raccontare e seguire la guerra non è né efficace né salutare: dopo dieci giorni ti sei già stancato. Sei assuefatto, fisiologicamente non ti stupisci più della guerra e vai oltre, facendo anche calare le letture.
Quando si racconta la guerra è meglio ragionare un po’ di più, e soprattutto raccontare in modo meno “immediato”, senza l’ansia di essere i primi, perché alla lunga non paga.
Come conciliare il racconto visivo della guerra evitando di sfociare nella spettacolarizzazione della violenza?
È una linea molto sottile, a volte troppo sottile: il problema infatti non è se fare la foto (perché in qualsiasi caso va fatta), ma come farla. Io non fotografo corpi, e se dovessi farlo lo farei comunque nel rispetto della persona e dello spettatore, ma è una cosa talmente soggettiva che può variare (purtroppo non c’è un antidoto).
Inserire un trigger warning potrebbe essere una soluzione dalla scrivania: il problema è stare sul campo e produrre quelle immagini.
Tu sei stato anche al confine con l’Ucraina, in Romania. In Europa c’è stato un approccio diverso dal solito nel raccontare l’immigrazione, pensi che dopo questa guerra possa cambiare il modo in cui viene raccontata l’immigrazione?
Io credo che tornerà tutto come prima, anche se abbiamo creato un precedente dal punto di vista politico, sociale e legislativo: abbiamo capito che si può fare e quindi adesso non ci sono più scuse.
Ci dovremo battere per applicarlo su altre rotte migratorie, ma è un bel precedente.
Quanto è importante, come giornalista che documenta la guerra, non improvvisare? E quanto è importante avere una conoscenza di base non solo in merito alla propria sicurezza ma anche in merito al Paese in cui ci si sta per recare?
Fondamentale: se improvvisi vuol dire che stai rischiando, se rischi diventi la notizia e se diventi la notizia invece di raccontarla vuol dire che non stai facendo bene il tuo lavoro.
È anche importante conoscere il Paese in questione prima di andarci: conoscerlo prima del conflitto e avere un bel po’ di contatti sparsi qua e là.